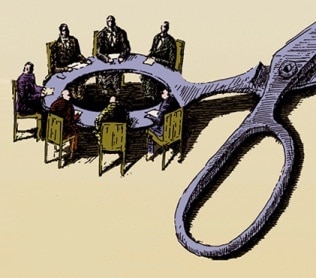Un miliardo è già stato messo sostanzialmente in cascina con il recente Dpcm sulla stretta ai ministeri. Occorrerà, probabilmente, trovare almeno altri 1-1,5 miliardi se non due. Almeno sulla base delle prime ipotesi grezze dei tecnici del Governo. La dote che dovrà garantire la “fase 3” della spending review per la prossima manovra autunnale, al netto delle scelte sulla revisione delle tax expenditures (si veda Il Sole 24 Ore del 21 luglio), dovrà essere solida e, soprattutto, visibile. Anche perché Bruxelles ha già fatto chiaramente capire che per concedere definitivamente il via libera (già in parte preannunciato nei giorni scorsi) all’utilizzo della nuova fetta di flessibilità per 8-9 miliardi chiesta dall’Esecutivo, dovrà essere sicura che l’Italia farà sforzi concreti per ridurre il debito e la spesa pubblica.
Il Governo vorrebbe anzitutto evitare un intervento troppo marcato sulle spese correnti anche per non tarpare le ali alla ripresa che sta mostrando tratti più marcati di quelli ipotizzati nei mesi scorsi. Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia sanno anche però che un segnale dovrà essere dato. Ma non sarà facile. In primo luogo perché la prossima legge di bilancio non potrà evitare in toto il vortice pre-elettorale e dovrà contribuire a rispettare alcuni impegni già presi dall’esecutivo, come il rinnovo del contratto del pubblico impiego. Che, da solo, dovrebbe assorbire circa 1,2-1,5 miliardi. Ma c’è anche un altro ostacolo da superare. I tecnici lasciano intendere che, non potendo toccare le pensioni e il sistema di Welfare in genere, i margini per interventi “incisivi” cominciano a essere molto stretti.
Il quadro emerso dopo l’approvazione dell’ultima legge di bilancio parla da solo: stando ai dati della Ragioneria generale dello Stato nel 2017 il 47% delle risorse del bilancio è destinato al finanziamento di interventi in materia di «Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno» e «Salute e istruzione», quasi il 14% finanzia la spesa per gli interessi passivi sul debito pubblico e circa l’11% riguarda i cosiddetti «Servizi pubblici generali»: ordine pubblico, sicurezza, giustizia e difesa. Gli altri fondi del bilancio vengono assorbiti per il 10% dalla categoria «Servizi istituzionali generali», per il 9% circa dagli «Affari economici» e per un ulteriore 7% circa dai «Trasferimenti agli Enti territoriali» (al netto di quelli per la sanità). L’1% delle risorse è convogliato sull’area «Cultura, ambiente e qualità della vita» e il 2 % è allocato nei «Fondi da ripartire».
Il Mef, per il momento, non si pronuncia. Anche se fa notare come una prima importante pietra nella costruzione del piano di riduzione della spesa da inserire nella prossima manovra sia stata posata con il varo del Dpcm che ha messo nero su banco tagli per 1 miliardo nel 2018 ai ministeri (in linea con quanto indicato nell’ultimo Def), di cui circa la metà direttamente a carico del dicastero di via XX settembre. Questa misura, tra l’altro, rende operativo il nuovo dispositivo vincolante per la spending review strutturale previsto dalla riforma del bilancio dello Stato, che, si fa notare dal Mef, è parte di un percorso ordinato destinato a crescere nel tempo. Da via XX settembre, insomma, non si escludono affatto altri tagli. Naturalmente molto dipenderà dalle componenti espansive della manovra autunnale, che avrà come obiettivo prioritario quello di sostenere e dare ancora più forza alla crescita.
Come ha fatto notare nelle scorse settimane il commissario straordinario alla revisione della spesa Yoram Gutgeld, dal 2014 a oggi sono state adottate misure che hanno prodotto a tutto il 2017 un “effetto-spending” di quasi 30 miliardi, anche se la ricaduta di riduzione di spesa in termini assoluti su base annuale è stata molto più limitata (per alcuni aspetti quasi impercettibile). La dote spending è stata infatti in gran parte riutilizzata per garantire sostenibilità ai conti pubblici e, in particolare, per coprire alcuni interventi più o meno strategici varati dal Governo negli ultimi 3 anni.
«La revisione della spesa – ha sottolineato lo stesso Gutgeld – ha creato circa due terzi delle risorse messe a disposizione per il conseguimento di tre importanti obiettivi: il risanamento dei conti pubblici (riduzione dell’indebitamento netto passata dal 3% del Pil nel 2013 al 2,4% nel 2016); la riduzione della pressione fiscale (passata dal 43,6% nel 2013 al 42,3% nel 2016, al netto degli 80 euro); il finanziamento dei servizi pubblici essenziali». Su quest’ultimo versante è stato indirizzato il grosso delle risorse recuperate con la spending: 12,7 miliardi per prestazioni previdenziali e assistenziali, 3,7 miliardi per la sanità, 3,4 miliardi inquadrati come spesa per migranti, 3 miliardi alla scuola e 1 miliardo alla sicurezza.
Individuare altri tagli strutturali senza intaccare delicati equilibri di bilancio e pre-elettorali non sarà facile. Da un’analisi della Rgs sull’andamento dei flussi di spesa primaria (quella al netto degli interessi) rispetto al Pil nel periodo 2009-2016 con proiezioni nel triennio 2017-2019 emerge che tutte le funzioni di spesa hanno un andamento decrescente, ad eccezione della protezione sociale (+6,8%) e della protezione dell’ambiente (+3,3%). Quanto all’incidenza delle macro-voci di spesa sulla spesa “primaria” complessiva, la “funzione” di uscita più rilevante resta quella della Protezione sociale: il 44,7% in media tra il 2009 e il 2015 (45,8% medio tra 2009 e 2019).
Marco Rogari – Il Sole 24 Ore – 4 agosto 2017